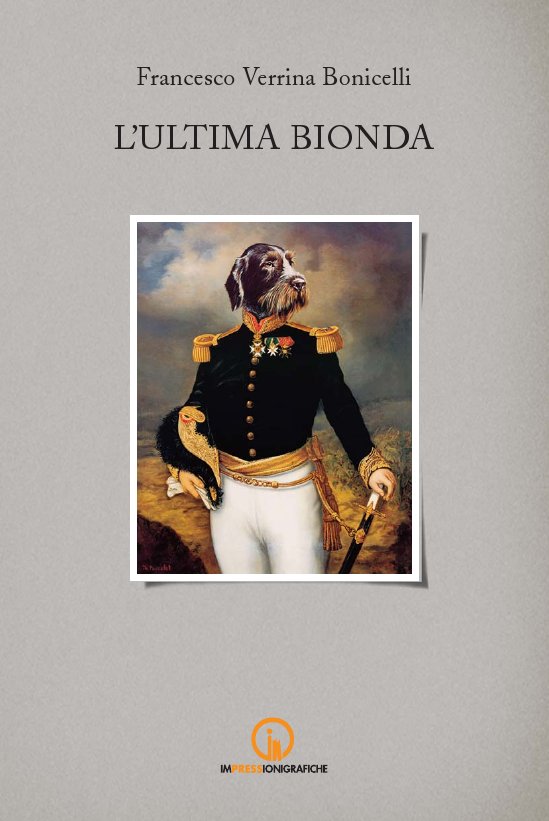“Oggi coniglio!” (come a dire, oggi, domani non so dove mangerò) aveva detto zio Luciano, zio materno, di Taberna Frigida quel giorno, avvicinandosi l’ora di pranzo. Le donne di casa, tre sorelle e tre cugine (adottate dalla nonna in quella casa a seguito di una funesta circostanza riguardante i loro genitori) ancora superstiti, pallide ma non sfiorite, religiosamente dedicatesi per tutta la vita ai pranzi della zio (vivendo sacrificate e zitelle negli ultimi angoli della casa rimasti sgombri da carabattole), abbandonarono immediatamente le loro faccende, chi scattando all’improvviso chi inciampandosi, chi scontrandosi l’un con l’altra, chi accennando uno sbadiglio, chi starnutendo e soffiandosi il naso per occuparsi del coniglio che era da qualche giorno in frigo, come se, d’improvviso, quel coniglio morto fosse diventato il centro dell’universo. Le zie da giovani erano state bellissime e avevano ricevuto centinaia di regali da certi bei fusti. erano tutti ancora da aprire, in solaio. Non che non ne fossero state lusingate, ma chi avrebbe poi badato al piccolo Luciano? Se tutta la gente della loro generazione aveva sacrificato la propria vita ad un’ideologia, loro di sicuro l’avevano sacrificata a un matto.
Quando lo zio muoveva verso la cucina, subito quelle sei donnine (che per la quantità di detersivi che usavano per mantenere tutto così lindo, diceva lo zio, stavano all’ambiente come un plotone di SS a un gruppo rom), con i lunghi capelli bianchi raccolti dietro la nuca, gli preparavano un sentiero di fogli di scottex, che né si bagnavano né si sporcavano, ma la minima possibilità che lo zio potesse bagnarsi le pantofole era così scongiurata.
Mi era sempre piaciuto quel modo di fare dello zio, di ordinare ed essere obbedito senza comandare, quasi consigliando anzi. Una forza di spirito che assolutamente non si può imparare se non lo si ha nel sangue, ed io nel sangue, certo, non l’ho. A volte non riesco che a considerarmi come una nave in porto, ferma a contemplare la propria stiva.
Avevo appena telefonato a una ragazza e questo mi aveva alquanto reso giù di morale. Era il funerale di suo padre non mi si poteva presentare occasione migliore, avevo meditato: mi sono sempre sentito a mio agio ai funerali, specie degli sconosciuti, e fin da subito premetto che questa sarà una storia piena di funerali. Lei mi aveva chiesto che cosa ne pensassi, non avevo resistito a rassicurarla che suo padre, a mio modesto avviso, non poteva certo stare peggio di quanto non stessimo noi, ma di sicuro non meglio, molto probabilmente non stava. Sostenni che c’erano prove lampanti ad avvalorare la mia teoria. Tentai di andare al sodo e di chiederle di vederci per bere qualcosa, lei accampò un’abusata scusa di astemia, allora provai il tutto per tutto raccontandole di quando avevo dovuto scrivere un pamphlet contro l’alcolismo e un giudice mi aveva condannato a cinquant’anni di sanbittér. Riattaccò.
Lo zio, un mese prima, in uno di quei rari giorni della sua vita in cui aveva messo il naso fuori dalla porta, aveva barcollato ed era caduto lungo in terra. Lo avevano canzonato quelli del bar sotto casa, perché chi vive in solitudine è sempre tacciato o di essere un pericoloso criminale sieropositivo o un povero scemo avvezzo a cosa di nessuna importanza come i libro, nel vicinato non aspettano altro che poterlo cogliere in fallo. Lo zio aveva detto: “No, miei cari ho i giorni contati, me lo sento, sono malato, di sicuro non sono un vecchio inetto”. Aveva fatto analisi per un mese e infine era riuscito a sbattere in faccia, a quanti gli avevano detto che era un vecchio rimbambito, i risultati che provavano uno stato avanzato della sua grave malattia, la quale non gli avrebbe lasciato più d’un paio di mesi di vita. “E prima o poi morirete anche voi, ma a me questo non riguarda, visto che il mondo finirà con me”. Tutti lo avevano compatito, se non deriso, ma nessuno aveva capito che i mondi sono tanti quanti gli esseri umani, quando ognuno di noi finisce con lui finisce un mondo, uno dei tanti possibili. Non faceva una piega. Da allora lo zio Luciano non era proprio più uscito di casa, se non sporgere la testa dalla finestra e scraccare di sotto dopo aver finito un toscano, e questa era una sua speciale abitudine che non aveva mai perso.
“Zio poi ti devo raccontare di una ragazza, forse le dovrei mandare un biglietto, è morto suo padre” dissi entrando in cucina, dove egli sovrintendeva alla preparazione del coniglio, come un alchimista agli esordi.
“E chi gli ha sparato?”
“Nessuno zio, ma a me interessa lei, almeno per ora”
“Emil, dopo il coniglio! E ad ogni modo non c’è donna che non sia lusingata dall’istupidimento di un uomo per lei. Ogni uomo innamorato è un pezzo ci ragionevolezza sottratto alla causa del buon senso e le donne sono le ambasciatrici del caos, dandoti però l’illusione che tu abbia bisogno del loro nuovo ordine irrinunciabile: un ordine tutto loro, che promettono di portare alla tua vita!”
Tutti sapevano in realtà che zio Luciano era un romantico cavaliere d’altri tempi, in fondo in fondo, dietro l’apparenza di misogino.
Nato a inizio secolo, pertanto mai arruolato per nessuna guerra, nel dopoguerra aveva conquistato centinaia di ragazze, o così si diceva raccontando loro di essere stato ricevuto da un discendente di Prete Gianni che lo aveva nominato “Principe del Guardaroba”, oppure di aver organizzato un colpo di stato in Congo, al seguito di un’equipe di fotografi di lucertole, e di essere poi all’ultimo dovuto scappare da una tribù di cannibali abbandonando i colleghi golpisti al loro destino, tutto questo, pare, quando faceva il cine-operatore da un continente all’altro ed aveva pure filmato le chiappe di Luis Armstrong (essendosi trovato di passaggio negli USA, ovviamente, per via di una sua mai spiegata nomination all’Oscar).
Odia l’alcool, come me, e per questo raccontava la bugia che io ogni tanto riciclavo della condanna al sanbittér. Era stato anche nel business delle bolle di sapone (“E che bei soldi!” commentava soddisfatto), diceva di tanto in tanto dandosi una qual certa aria d’importanza e ogni tanto ne soffiava qualcuna dalla finestra, ma non sopportava i bambini e affermava, contro ogni evidenza, di non esserlo mai stato. Anzi, quando vedeva dei bambini soffiare bolle di sapone, il suo massimo divertimento era rincorrerle e scoppiargliele sotto gli occhi. Questo era solo uno dei tanti divertimenti, infatti fra gli altri vi era quello di travestirsi da prete per farsi offrire il pranzo nei ristoranti; oppure fingersi cieco al mercato percuotendo con un bastone i malcapitati passanti a destra e a manca, seminando il terrore e nello stesso tempo una sgomenta costernazione per la sua disgraziata sorte, tanto che, chi lì per lì si arrabbiava vedendo poi quell’omino cieco, che non sapeva dove poggiare il bastone e chiedeva tante volte scusa a tutti quelli che colpiva subito era mosso alle lacrime fino ad accoglierlo in casa per pranzo o per cena o a offrirgli almeno un caffè o qualche spicciolo, qualche donna addirittura gli si sarebbe concessa. Soprattutto lo zio non sopportava la serie di ricordi della sua drammatica infanzia passata rincorrendo un po’ di tempo da dedicare ai suoi personaggi da inventare, leggere, fantasticare, fra un’ora di tennis e una di nuoto impostegli dal padre, sempre in viaggio lontano, ma pesantemente presente, dal quale non aveva ricevuto più di “un sacco di randellate nel culo”, l’avevo udito ricordare una volta. Ad ogni modo, lo zio, sosteneva persino di aver visitato alcune città sulla Luna alla ricerca di un certo Astolfo, e di aver combattuto una battaglia nella pancia di una balena. Fra le altre cose, raccontava di avere un testicolo solo per averne dovuto piantare uno nella terra delle Amazzoni dov’era andato a vendere dei grammofoni. Là, sosteneva, le Amazzoni coltivano maschi in quel modo, copulano in estate e in autunno li mietono.
Scriverle tutte sarebbe uno sforzo immane, ne aggiungerò di tanto in tanto lungo la storia, anche se non potrò mai veramente darvi l’idea di chi fosse mio zio, il conte Luciano Terrasanta.
ACQUISTA IL LIBRO